Marx e Galdstone: schiavitù, lavoro e povertà
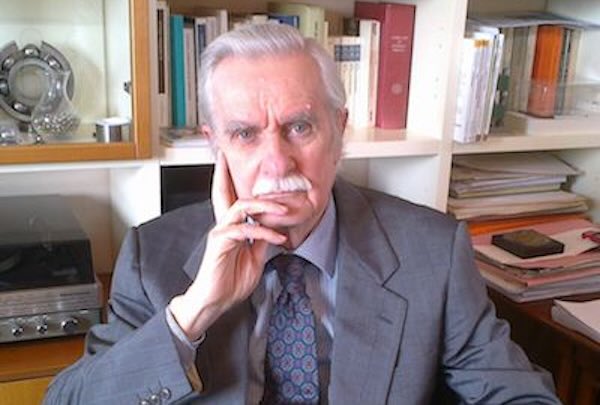
Non ci sono dubbi che Karl Marx (1818-1883) fosse molto contrario alla schiavitù. Il primo volume del “Capitale” in lingua inglese (Londra 1867), contiene critiche e riferimenti specifici riportando un lungo tratto del lavoro di John Elliot Cairnes “The Slave power” del 1862”.
Marx stesso manifesta la sua soddisfazione per le novità statunitensi del 1860 (abolizione della schiavitù) già nella prefazione del suo capolavoro: “Non si può, tuttavia disconoscere qui un certo progresso… I rappresentanti della Corona britannica all’estero ammettono che, in molti paesi civili del continente, una trasformazione nei rapporti fra capitale e lavoro oggi esistente, è altrettanto percepibile e altrettanto inevitabile, quanto in Inghilterra. Contemporaneamente, al di là dell’atlantico, il signor Wade, vicepresidente degli Stati Uniti del Nord America, parlava così in pubbliche assemblee: “Soppressa la schiavitù, passa all’ordine del giorno la trasformazione dei rapporti del capitale e della proprietà fondiaria”.
Importante la trattazione di Marx sulle lotte per la giornata lavorativa normale, in cui inizia proprio dalla schiavitù per un parallelismo con gli operai europei. “Il proprietario di schiavi compera il suo operaio come acquista un cavallo. Perdendolo, perde un capitale e dovrà sostituirlo mediante nuova spesa sul mercato degli schiavi, ma (e qui Marx fa continuare Cairnes): “considerazioni economiche che potrebbero offrire allo schiavo una certa garanzia di trattamento umano identificando l’interesse del padrone col mantenimento in vita dello schiavo stesso, si trasformano, dopo l’introduzione della tratta degli schiavi, in ragioni di completa rovina e distruzione dello schiavo perché, non appena l’importazione di braccia di riserva straniere di colore permette di occupare il posto, la durata della sua vita diventa, finché dura, meno importante della sua produttività.
Perciò è una massima schiavistica, il metodo più efficacie di condurre l’azienda, consiste nello spremere dal gregge umano, il maggior rendimento possibile nel minor tempo possibile. Per questo, è l’agricoltore delle Indie Occidentali che ha divorato milioni di uomini africani; oggi è a Cuba, dove i redditi assommano a milioni e i piantatori sono come principi, che vedono non solo gli schiavi soffrire di una alimentazione delle più miserabili e di vessazioni delle più accanite e logoranti, ma una parte della loro classe perisce ogni anno per la lenta tortura dell’eccesso di lavoro e della mancanza di sonno e di ristoro”.
Da qui, Marx riprende alla sua maniera:
“Mutato nomine de te fabula narratur (con altro nome è di te che si parla; Orazio, Satire). Invece di tratta degli schiavi, leggi mercato del lavoro; invece di Kentucki e della Virginia, leggi Irlanda e i distretti agricoli di Inghilterra, Scozia e Galles; invece di Africa, leggi Germania! Abbiamo sentito come a Londra il superlavoro faccia strage di garzoni-fornai: eppure il mercato del lavoro londinese è sempre zeppo, per l’arte bianca, di candidati alla morte, tedeschi o altri. L’industria ceramica, si è visto, è uno dei rami in cui la durata della vita è più breve: forse che per questo mancano i vasai?... L’industria cotoniera ha novanta anni e in tre generazioni della razza inglese essa ha divorato nove generazioni di operai cotonieri!
Perciò, il capitale non ha riguardo per la salute e la durata della vita dell’operaio, finché la società non lo costringa con la legge ad averne”.
Il primo volume del Capitale è ricchissimo di riferimenti alla politica e all’economia inglese. Marx del resto è vissuto molti anni in Inghilterra e ha avuto modo di studiare e criticare molti aspetti di quel sistema economico, senz’altro capitalistico, gestito da conservatori e liberali. I temi sono quelli della povertà, della disuguaglianza e del lavoro ad iniziare da quello dei fanciulli per mezzo del cosiddetto sistema “relais” (alla lettera cambio dei cavalli) di cui Marx scrive: “Venne messo in esecuzione in modo che, per esempio, si aggiogasse al carro una squadra di fanciulli di età compresa fra nove e tredici anni, dalle 5,30 alle 13,30, un’altra dalle 13,30 alle 21,30 e così via”.
Sempre aspre le sue polemiche con un grande personaggio inglese, più volte ministro e per quattro volte capo del governo William Ewart Gladstone (1809-1897) nobile, prima conservatore e poi liberale e dunque del tutto lontano come condizione e idee da Marx, il quale non perdeva occasione per criticarlo come riporta sul “Capitale”. Lo chiamò ministro tutto unzione quando nel febbraio del 1843 si espresse in questi termini: “Uno degli aspetti più malinconici dello stato sociale del paese è che contemporaneamente a una diminuzione del potere di consumo del popolo e ad un aumento delle privazioni e della miseria dei lavoratori, si verifichino una accentuazione costante di ricchezza nelle classi superiori e un continuo aumento del capitale”.
Vent’anni dopo, nell’aprile del 1863, da presidente del consiglio disse: “Se i ricchi sono diventati più ricchi, i pover sono diventati meno poveri; ma, che gli estremi della miseria siano diminuiti non oso dire”. E Marx, ricordando le sue affermazioni di vent’anni prima risponde: “Se gli estremi della miseria non sono diminuiti, allora sono aumentati, perché sono saliti gli estremi della ricchezza”. Anche il successivo discorso sul bilancio del 1864, è oggetto di critiche. Gladstone riferisce di rami dell’industria dove il salario non è cresciuto, dei progressi dell’arricchimento e riassume la felicità della classe operaia in questa incredibile frase: “ La vita umana in nove casi su dieci è una pura lotta per l’esistenza”. Marx definisce nel complesso tutto l’intervento come un “ditirambo pindarico” per intendere un parlare confuso, esagerato, enfatico e retorico. Insomma, l’unica certezza è che i due non erano proprio in sintonia.
Non credo che Marx ignorasse le ricchezze di Gladstone, ma forse non fino al punto di conoscere natura ed entità di tutte le proprietà, perché la sua famiglia possedeva anche molti schiavi.
La legge inglese sull’abolizione della schiavitù del 1933 (Gladstone aveva allora ventiquattro anni ed era laureato in giurisprudenza) previde un risarcimento integrale dei proprietari di schiavi con tariffe variabili in funzione dell’età e della produttività dei singoli, e una spesa complessiva di 20 milioni di sterline a partire dallo stesso anno, versati ai circa 4.000 proprietari, importo corrispondente al 5% del reddito nazionale del Regno Unito dell’epoca.
Gli archivi parlamentari sono stati oggetto di uno studio sistematico che ha portato alla messa online del database completo nel 2010. Da questo studio emerge che la famiglia Gladstone ricevette ben 106.769 sterline per 2.508 schiavi, tutti occupati nelle loro nove piantagioni!
Per avere solo un’idea dell’entità di tale somma, riporto il risultato di uno studio elaborato da “Storia in Rete” del 2013 che stima, a tale data, in circa 80 milioni il rimborso ottenuto. Naturalmente calcoli precisi sono praticamente impossibili, ma sappiamo che 20 milioni di sterline nel 1833 erano pari al 5% del reddito nazionale del Regno Unito che, vale la pena sottolinearlo, destinava all’istruzione lo 0,5%. Quindi per i proprietari di schiavi vennero destinati somme equivalenti a dieci anni di sostegno all’istruzione!
La legge sull’abolizione della schiavitù e sul ristoro dei proprietari è, come abbiamo detto, del 1933 e Marx in quell’anno era ancora al liceo di Treviri dove si diplomò due anni dopo per iscriversi all’università di Bonn. Non credo che allora si occupasse della politica inglese, ma sul “Capitale” studia diffusamente i provvedimenti del parlamento inglese dell’anno 1833, perché venne varata la “Legge sulle fabbriche” e con essa le disposizioni sull’orario di lavoro degli operai.
Insomma, mi sembra difficile che Marx non conoscesse l’altra legge del 1933, la sua onerosità per le casse dello stato e il dibattito sulla “moralità” del risarcimento, più che consistente, al proprietario anziché allo schiavo. D’altra parte, se la conosceva, perché non si è mai pronunciato in merito sui tre libri del “Capitale”, mentre dibatte con dure polemiche su tanti altri temi sicuramente meno importanti.
Forse, d’accordo sulla fine della schiavitù, non ritenne di entrare nel merito dei risarcimenti.
Se qualcuno dei gentili lettori volesse esprimere la propria opinione in merito, ne sarei molto grato.
 orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.
orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.
Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.